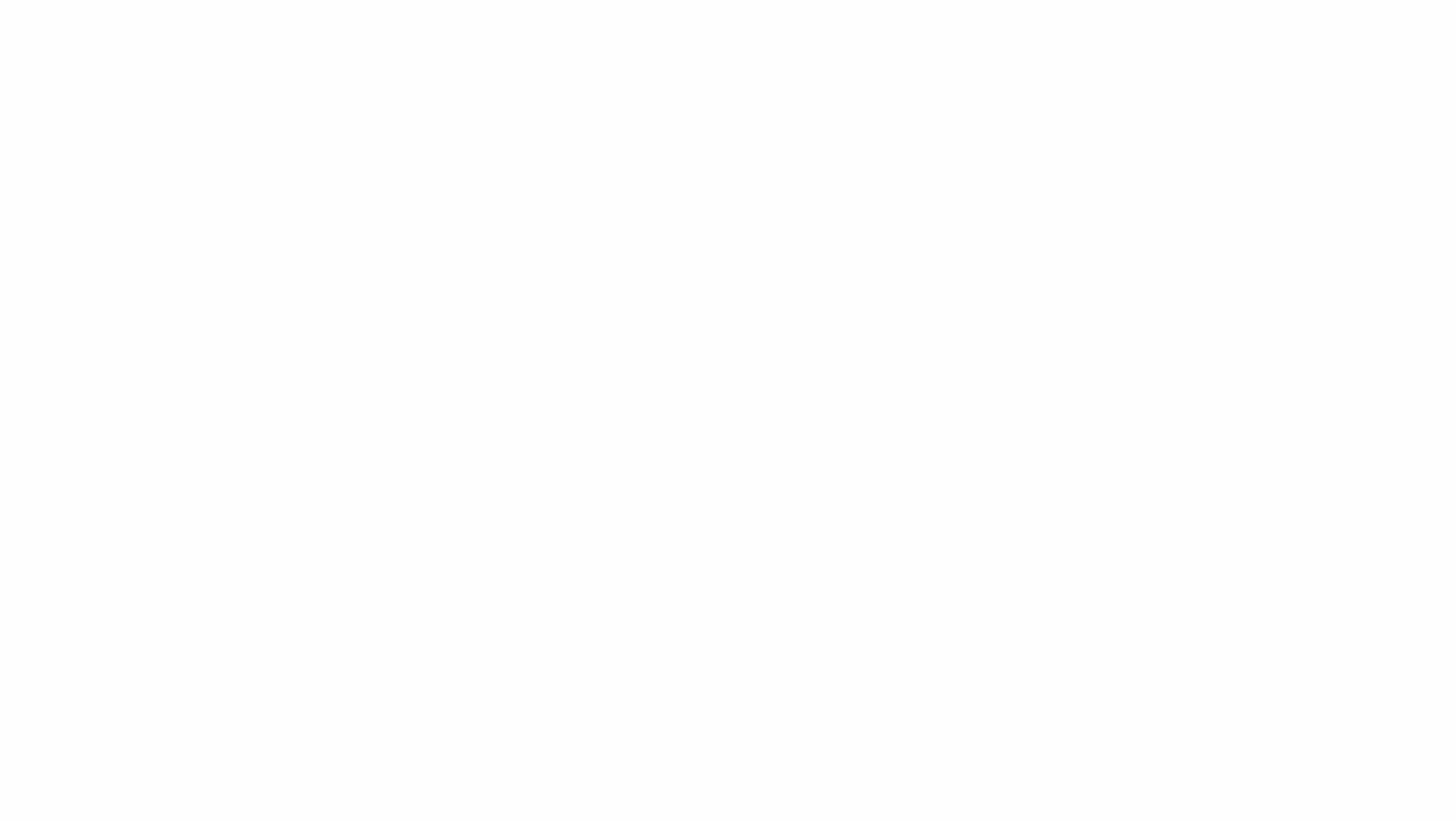Santa Rosalia 2019, il discorso di Mons. Lorefice: “No alla spietata massima del prima noi”

Non possiamo essere donne e uomini del ‘si salvi chi può’, donne e uomini che mancano al loro stesso essere, trascinati dall’indifferenza, dalla preoccupazione per se stessi, secondo la spietata massima: ‘prima noi!’”. Ad affermarlo l’arcivescovo mons. Corrado Lorefice, nel suo discorso alla città, pronunciato a piazza Marina, in occasione del festino in onore della patrona, santa Rosalia. “Vogliamo essere dinanzi al diluvio costruttori di arche della salvezza e della custodia, dove entreremo per ultimi, dopo aver fatto spazio a tutti”. Poi citando le parole di Papa Francesco ad Abu Dhabi, ha ripreso l’immagine dell’arca: “Penso a tre arche da mettere su in fretta, per custodire la casa comune, il creato, e per porre i presupposti dell’arcobaleno, della nostra rinascita”. La prima “arca da costruire, la prima realtà del creato da proteggere sono i corpi, i corpi concreti, i corpi di carne”. Poi, le case e le famiglie e, infine, la città. Anzitutto, il riferimento ai “corpi tanto reali quanto invisibili, che si annidano nelle macerie della storia, distrutti da una corrente gelida di annientamento e di indifferenza”. Una situazione che – ha sostenuto l’arcivescovo – genera sgomento. “È lo sgomento che ci afferra al cospetto dei barconi affondati, dei campi di concentramento libici, che continuano la loro sistematica distruzione nazista dell’umano con la nostra colpevole complicità, dei popoli dell’Africa e del Sud del pianeta, martoriati dallo sfruttamento dell’Occidente, ridotti allo stremo e alla morte, lo sgomento davanti a tutti i corpi viventi che finiscono la loro avventura nel non senso, nell’abisso del nulla”.
Corrado Lorefice Arcivescovo Metropolita di Palermo FESTINO DI S. ROSALIA Discorso alla città
Piazza Marina – 15 luglio 2019
Care Palermitane, Cari Palermitani,
siamo di nuovo qui in piazza, stasera, attorno a Rosalia, in un anno e in un tempo segnati dall’inquietudine e dall’emergenza. Vicinissimi, insomma, alle sensazioni tipiche dell’evento catastrofico nel quale la nostra Santa si mostrò, quattrocento anni or sono, propiziatrice di salvezza. Era la peste allora – per lei e per Palermo – a rappresentare la sorgente di uno smarrimento, di una disperazione che il saponaro Vincenzo Bonelli rese simbolicamente con il proprio desiderio di morte dopo la perdita della giovane moglie.
Anche noi arriviamo qui stasera provati, portandoci nel cuore un senso di oppressione per le vicende della nostra terra, dell’Italia, del mondo tutto. La catastrofe contemporanea non è quella di un’epidemia contagiosa ma di un diluvio opprimente, che sommerge e affoga: il diluvio della costruzione da parte dell’uomo di un sistema economico planetario che schiaccia i poveri e ferisce la natura; [il diluvio] di un gioco di relazioni segnate dalla separatezza, dalla diffidenza, dall’esclusione del diverso, dell’altro, comunque lo si voglia configurare; [il diluvio] di una Chiesa che fatica a sintonizzarsi sulla linea d’onda del Vangelo, trasmessaci dal Santo Padre e contrastata da messaggi e comportamenti divisivi e aspramente aggressivi.
Di fronte a tutto questo noi – tutti noi, presenti in questa piazza – siamo rimandati all’icona di una ragazza, – Rosalia de’ Sinibaldi –, che durante la sua vita ebbe il coraggio di opporsi a convenzioni e a interessi di classe; ebbe la forza di rimanere fedele a sé stessa e di farsi carico di scelte difficili, in nome di una responsabilità personale accettata sino in fondo. Voglio dirvi cioè – care donne e cari uomini di Palermo – che la nostra familiarità verso la Santuzza non è pensabile come una
devozione a buon mercato, che ci confonda in una folla anonima in cui ognuno può farsi una Rosalia a proprio uso e consumo, può continuare la propria esistenza senza scosse, senza crisi. Essere rimandati a Rosalia di fronte alla catastrofe significa stasera per ognuno di noi uscire dalla folla, dalla sua indistinzione, dalla sua comodità; tirarci fuori dalla calca che giudica rozzamente, che segue il puro istinto e l’immediata convenienza; sottrarci alla frotta che urla sui social ed è pronta a raccogliere i messaggi qualunquistici di conflitto aperto e di violenza. Come scriveva Simone Weil nel 1943: «Siamo arrivati al punto di non pensare quasi più, in nessun ambito, se non prendendo posizione ‘pro’ o ‘contro’ un’opinione e cercando argomenti che, secondo i casi, la confutino o la supportino. […] [Questo] Significa aver perso completamente il senso del vero e del falso» (Manifesto per la soppressione dei partiti politici, Pubblicato nel numero 26 della rivista francese “La Table Ronde” del 1950).
Ve lo dico in maniera chiara e lo dico anzitutto a me stesso, stasera: se siamo qui con questo spirito non siamo devoti di Rosalia, non ne abbiamo capito nulla! Rosalia ci chiama ad essere responsabili, ad essere insieme come popolo. Non massa, ma comunità di singoli, di persone libere e pensanti, che sentono la chiamata ad operare il bene e la giustizia nello spazio proprio della loro vita, pronte (e pronti) a pagare di persona la libertà del loro pensare e la loro condivisione con i più svantaggiati, con chi è diventato puro ‘scarto’ della società globale e della «cultura dell’indifferenza» (Papa Francesco).
Quella ragazza coraggiosa – Rosalia – apparve, si levò, nei giorni della peste, per custodire Palermo. Seguirne le orme vuol dire per noi affrontare con coraggio l’abisso, non temere il diluvio – di parole vuote, di gesti arroganti, di impulsi violenti, di strategie di potere –, decidere di ascoltare la parola della nostra Patrona che ci spinge a proteggere e a salvaguardare Palermo, il nostro paese, il nostro mondo. Non possiamo essere donne e uomini del «si salvi chi può», donne e uomini che mancano al loro stesso essere, trascinati dall’indifferenza, dalla preoccupazione per sé stessi, secondo la spietata massima: «prima noi!».
Noi no! Vogliamo essere dinanzi al diluvio costruttori di arche della salvezza e della custodia, dove entreremo per ultimi, dopo aver fatto spazio a tutti. Papa Francesco ad Abu Dhabi (4 febbraio 2019), riprendendo il racconto biblico, ha parlato dell’arca, ed è forse questa l’unica immagine di casa che ci è confacente quest’oggi: «abbiamo bisogno di entrare insieme, come un’unica famiglia, in un’arca che possa solcare i mari in tempesta del mondo: l’arca della fratellanza».
Penso stasera a tre arche da mettere su in fretta, per custodire la casa comune, il creato, e per porre i presupposti dell’arcobaleno, della nostra rinascita. Ne approfitto per dire grazie ai detenuti dell’Ucciardone che hanno costruito e trasportato quest’anno la meravigliosa “arca” della Santuzza.
La prima arca da costruire, la prima realtà del creato da proteggere sono i corpi, i corpi concreti, i corpi di carne. Le persone. La nostra arca deve innalzarsi per custodirli. Penso ai corpi eliminati da mani violente, ai corpi stuprati, ai corpi dei bambini violati o investiti sulle nostre strade, ai corpi travolti dalle alluvioni, a tutti i corpi affondati, ai corpi scomparsi, ai corpi degli anziani, dei disabili abbandonati, ai corpi feriti; i corpi dei poveri della nostra città, degli oppressi e dei vinti della terra; come dire, [penso] alla faccia del mondo sottratta alla nostra vista.
Un esercito di corpi tanto reali quanto invisibili, che si annidano nelle macerie della storia, distrutti da una corrente gelida di annientamento e di indifferenza. Un pensatore ebraico, morto suicida per sfuggire all’arresto da parte dei nazisti – si chiamava Walter Benjamin –, immaginò in un suo testo che queste macerie della storia umana fossero fissate con occhi sbarrati da un Angelo, trasportato via di spalle dal vento del progresso, con le ali impigliate e lo sguardo attonito. Quell’Angelo, rappresentato nel quadro di un grande pittore svizzero-tedesco, Paul Klee, a cui Benjamin si era ispirato, mi pare l’immagine appropriata del nostro sgomento, del dolore messianico. È lo sgomento che ci afferra al cospetto dei barconi affondati, dei campi di concentramento libici (che continuano la loro sistematica distruzione nazista
dell’umano con la nostra colpevole complicità), dei popoli dell’Africa e del Sud del pianeta martoriati dallo sfruttamento dell’Occidente, ridotti allo stremo e alla morte, lo sgomento davanti a tutti i corpi viventi che finiscono la loro avventura nel non senso, nell’abisso del nulla.
Sia la nostra Città, sia la Chiesa di Rosalia e di Pino Puglisi, [sia] per questi corpi, accolti nell’arca, l’Angelo della custodia e della speranza. Perché noi non ci nascondiamo il volto terribile e angosciante della storia. Eppure – e mi rivolgo a tutti i credenti di questa piazza, a tutti i giusti, a tutti i testimoni del bene – mentre gridiamo raccolti attorno a questi corpi e con loro, alzando la nostra voce verso il cielo, sappiamo, al di là di ogni apparente evidenza, che c’è speranza. Noi infatti crediamo nei corpi, ed è questa fede che portiamo stasera, che da vescovo sento di dover gridare in questa nostra piazza.
Crediamo nei corpi. Crediamo nel corpo che è principio di tutto, il corpo creato dal Dio della Genesi a sua immagine, a sua somiglianza (come a dire che nel corpo abita il seme indistruttibile della dignità e della bellezza del vivente). Crediamo nel corpo del «più bello tra i figli dell’uomo» (Sal 44, 3) che ci dà la salvezza, il corpo incarnato di Gesù che si approssima totalmente alla nostra fragilità e alla nostra morte e solo così ci solleva verso il Padre; senza il corpo di carne, infatti, non c’è salute: «Caro cardo salutis» (Tertulliano). Crediamo nel corpo glorioso del Risorto, icona certa del nostro futuro, corpo trasfigurato in quanto corpo amante e crocifisso, che ci ricorda l’energia vitale dimorante nella nostra carne. Crediamo, così recita la Lettera Placuit Deo, «nell’economia corporale» dei sacramenti (Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della salvezza cristiana, 14), al loro essere segni efficaci della grazia, segni impressi sui corpi, se carne e sangue del corpo amante del nostro Signore è per noi l’Eucaristia, di ogni sacramentum modello e paradigma.
Accogliamo nell’arca i corpi che parlano di vita, generati come sono dal corpo vivente di una donna; che parlano di amore, perché fatti per aprirci radicalmente alla cura dell’altro; corpi che dicono la nostra tensione verso l’infinito, verso l’oltre – «non
di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Dt 8,3; Lc 4,4): e quindi senza questa parola, collocata al di là di noi, i corpi non possono vivere –,e [corpi] che pur ci rammentano ogni giorno il limite invalicabile della nostra condizione. Quel limite che oggi facciamo fatica ad accettare e che ci conduce sulle strade impervie e disperanti del post-umano, mentre la via della speranza dischiusa nell’arca è quella dell’ascolto del corpo, del suo rispetto, la via del limite e della misura, essenziali perché i corpi si riconoscano nell’amore. «Se noi lealmente affermiamo i limiti […] costruiamo i rapporti d’equilibrio del nostro essere. E questa è ‘infinità finita’, compimento» (Romano Guardini, L’opposizione polare).
Nella seconda arca che vogliamo apprestarci a costruire, ospitiamo e custodiamo le nostre case e le nostre famiglie. Custodiamo cioè la fatica e la bellezza del vivere assieme di ogni coppia, la dignità mai giudicabile di ogni amore, di ogni slancio appassionato verso l’altro in cerca di felicità. Dopo millenni infatti, per la prima volta, da pochi decenni, nelle società occidentali non si sceglie di vivere assieme e di condividere la vita per un contratto economico e per una necessaria perpetuazione della stirpe, ma si decide di fare coppia perché si scommette sulla relazione, si spera di poter trovare la felicità nell’incontro con l’altro. È un modo sorgivo di fare l’esperienza dell’essere in due, molto più prossimo al progetto di Genesi di quanto non lo sia stato una concezione del matrimonio nel passato. Ma dove tutto è rimesso alla relazione, la fragilità è massima. Quanto è facile innamorarsi, quanto è difficile durare, attraversare le crisi evolutive che nel tempo ci maturano e ci insegnano una convivenza feconda e rispettosa! È questa spinta meravigliosa e questa fatica immane che siamo chiamati a custodire nell’arca. La nostra mano – e penso qui naturalmente alla mia, alla nostra, alla mano del vescovo e della Chiesa di Palermo – nel segreto riparo del sottocoperta, deve protendersi per accarezzare il tentativo generoso di tutti: le case – ordinate o scombinate, equilibrate o disastrate, regolari o irregolari – hanno tutte diritto alla carezza consolante del Vangelo sotto l’infuriare del diluvio dell’analfabetismo
affettivo, dello sfruttamento dei corpi, della mancanza di comunicazione, della tensione frustrata al dialogo e all’incontro.
E custodire le case significa custodire le giovani generazioni, i figli che da questa nuova forma del vivere assieme vengono generati e che appare sempre più complesso educare e consegnare alla vita. Si tratta infatti di mettere assieme l’essere e il divenire. S. Agostino direbbe: l’amor e l’ordo (Cfr. Agostino D’Ippona, De civitate Dei, libro XV, cap. 22). Accettare incondizionatamente quel che i nostri figli sono ed esprimono (l’amor), e intanto orientare il loro approssimarsi al mondo grazie ad una relazione di cura in cui ci si sappia prendere la responsabilità di essere genitori, educatori, mettendosi e mettendo i figli al posto giusto (l’ordo): «l’amore come ordo amoris» (G. Salonia). Portiamo con noi nell’arca l’esempio della famiglia di Nazareth. Per come ce la racconta Luca, quella famiglia può ancora aiutarci, se pensiamo già solo all’episodio di Gesù dodicenne allontanatosi da Maria e Giuseppe per discutere con i dottori nel tempio, a Gerusalemme. È una famiglia in cui Gesù è libero di muoversi eppure certo non abbandonato; è rispettato nella sua diversità eppure custodito nel cuore di Maria (e di Giuseppe), nel silenzio e nella fiducia; è autonomo eppure chiaramente definito come figlio. C’è accettazione amorosa e definizione serena dei posti di ognuno a Nazareth, e noi pensiamo che grazie al sostegno di questo amore concreto, totalmente umano, il Figlio di Dio ha potuto intraprendere, nutrito e guidato, la sua missione nel mondo.
Nella terza arca che costruiremo in fretta per far fronte al diluvio, siamo chiamati a custodire le città. È questa l’arca della politica, nella quale i corpi e le famiglie, i corpi e le case imparano a stare assieme in un modo nuovo. Si tratta di dar vita a una civiltà diversa, di essere nell’arca la culla di una politica rinnovata, che pensa la città e la crea secondo la chiamata del tempo, all’altezza dei «segni dei tempi», eredità imperitura di Giovanni XXIII. Nella città che vogliamo custodire nella nostra arca al posto dei muri ci sono le mani, strette le une alle altre, senza distinzioni di culture, di religioni, di colori. Perché la politica che ascolta i corpi considera l’umano
come il fondamento del suo essere. E dunque non ha bisogno di barriere protettive, ma si protegge con il cerchio descritto dalle mani di tutti. Un cerchio che non esclude ma è per sua natura permeabile e inclusivo. Queste città custodite nella nostra arca sono allora ‘patrie non patrie’, patrie delle donne e degli uomini di ogni patria; città in cui tutti siamo di casa e tutti ne siamo fuori; tutti padroni e tutti ospiti; tutti a nostro agio e tutti stranieri e pellegrini, come ci ricorda meravigliosamente l’A Diogneto: «Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera» (V, 4-5).
Nella città che va nascendo, nel caldo cuore dell’arca, non vigono più le separazioni fittizie tra il popolo e le élites, a più riprese evocate dagli opinionisti nei mesi precedenti. Scopriamo infatti ogni giorno che l’arca è unica, è di tutti e per tutti. E la nostra città non ha bisogno di progetti élitari di dominio, ma [ha bisogno] di riscoprire – come pensa Papa Francesco, che ritorniamo a ringraziare per la ricchezza e la bellezza della sua visita e per le parole che ancora dentro di noi sono un seme di rinnovamento – [riscoprire] l’accordo nel vivere assieme, costruendo le condizioni dell’incontro nell’ascolto di tutti, nell’accoglienza della storia di ognuno. Prima di qualunque ruolo, mansione o posizione, siamo donne e uomini che si portano dentro una storia. La città che nasce nell’arca è la città che offre a tutti l’opportunità di raccontarla. I princìpi si contrappongono, le storie si ascoltano. Le regole astratte si elidono a vicenda, le differenze convivono. L’imposizione spacca, la giustizia misura. La sintesi dei più forti è il prevalere di una parte, l’unità che conserva tutte le diversità rende la città nascente un grande, stupefacente poliedro (Papa Francesco).
E lasciatemi dire che è questo il mio sogno per Palermo. [Lasciatemi dire] Che io sogno una Palermo così. «Talithà kum!». Svegliati e alzati, Palermo, sii capitale degli incontri e dei confronti; [sii] capitale delle mani strette e dei racconti lunghi; [sii] capitale aperta alle differenze e gioiosa della sua tradizione; [sii] capitale del mare e della terra, della giustizia e dell’accoglienza. Della bellezza dei monumenti custoditi,
delle strade pulite, dalle piazze verdi, del traffico ordinato, dello sport umano e corretto, dell’ecologia e della pace.
E sogno anche una Chiesa così, nella nostra Palermo: intrepida nella testimonianza, unita nell’amore, mai divisa di fronte alle esigenze del Vangelo, capace di umiltà e di ascolto, ma pronta a gridare per salvare il diritto dell’orfano e della vedova (e il nuovo Statuto e Carta Pastorale della Caritas ci conducono su questa via). Rosalia ci insegna – lo dicevamo all’inizio – che il sogno rimane però puramente velleitario se non c’è da parte di tutti noi responsabilità e corresponsabilità.
Quarant’anni fa moriva Enrico Berlinguer, che soprattutto negli ultimi anni della sua testimonianza politica aveva intuito la centralità della responsabilità etica e la necessità di un rinnovamento linguistico della politica. Egli diceva che «la questione morale […] è diventata la questione politica prima ed essenziale perché dalla sua soluzione dipende la ripresa di fiducia nelle istituzioni, l’effettiva governabilità del paese e la tenuta del regime democratico». E da dirigente e da uomo delle istituzioni si sottraeva sdegnosamente alla politica delle invettive e degli insulti: «Io le invettive non le lancio contro nessuno, non mi piace scagliare anatemi, gli anatemi sono espressione di fanatismo e c’è troppo fanatismo nel mondo» (Cit. in W. Veltroni, Quando c’era Berlinguer, Rizzoli 2014). Quanto avremmo bisogno nella nostra nazione e nella nostra città di donne e di uomini che sentano la politica così!
Se la barbarie sembra dietro l’angolo, l’arca custodisce le possibilità di un equilibrio diverso, aiutandoci a vedere la potenza nascosta del cambiamento che passa attraverso la concretezza delle esistenze e prepara un orizzonte nuovo. Lo stesso orizzonte intuito più di quarant’anni fa da Aldo Moro, non per nulla compagno di cammino con Berlinguer di un’idea di cambiamento profondo dell’Italia messa allora momentaneamente a tacere dalle pallottole delle Brigate Rosse. Diceva Moro: «Tempi nuovi si annunciano e avanzano in fretta come non mai. Il vorticoso succedersi delle rivendicazioni, la sensazione che storture, ingiustizie, zone d’ombra, condizioni d’insufficiente dignità e d’insufficiente potere non siano oltre tollerabili, l’ampliarsi del quadro delle attese e delle speranze all’intera umanità, la visione del diritto degli
altri, anche dei più lontani, da tutelare non meno del proprio, il fatto che i giovani, sentendosi a un punto nodale della storia, non si riconoscano nella società in cui sono e la mettano in crisi, sono tutti segni di grandi cambiamenti e del travaglio doloroso nel quale nasce una nuova umanità. […] Nel profondo, è una nuova umanità che vuole farsi, è il moto irresistibile della storia. Di contro a sconcertanti e, forse, transitorie esperienze c’è quello che solo vale e al quale bisogna inchinarsi, un modo nuovo di essere nella condizione umana» (Discorso al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, 21 novembre 1968).
Intercedano stasera per noi il corpo della nostra Rosalia, il corpo dei nostri martiri e in primo luogo quello del beato Pino Puglisi; accanto a loro rivolgiamo lo sguardo al corpo risorto del Signore, alla casa di Maria e di Giuseppe a Nazareth, alla santa Gerusalemme, città della pace: ci diano loro il coraggio di custodire l’arca dei corpi di carne, di abitare l’arca delle case degli uomini, di costruire l’arca delle città- poliedro. Perché possiamo intravedere insieme l’alba di un mondo nuovo, l’arcobaleno di una nuova umanità. Buona festa a tutti! Viva Palermo e Santa Rosalia!